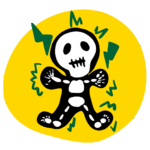Jacopo Marcello, originariamente edito in Charta, 170, pp. 68-71.
Ricordare è un verbo che riteniamo innocuo, che utilizziamo, forse anche un po’ sbadatamente, nella vita di tutti i giorni: ci ricordiamo di fare la spesa, o non ci siamo ricordati questa o quella commissione. È una parola semplice, facile da utilizzare – un po’ come Maus – che versiamo di continuo nella coppa della nostra quotidianità senza riflettere, se non quando ci accorgiamo che vorremo proprio scordarci di una persona o di un avvenimento che ci fanno soffrire ma non ci riusciamo.
In quei momenti capiamo che per quanto possiamo allenare la nostra memoria non si può controllarla, è come una marea che sale e si ritira seguendo regole sue proprie, indipendenti dalla nostra volontà. Non possiamo scegliere ciò che ricordiamo né ciò che dimentichiamo. Non abbiamo nessun potere su di essa, perché tutta la nostra personalità è stata scolpita nel duro basalto dei nostri ricordi. Perché se è vero che noi siamo le esperienze che abbiamo vissuto, tuttavia è il loro ricordo (o il loro oblio) a influenzarci giorno dopo giorno fino a renderci quelli che in definitiva siamo.
Ed è il ricordo, proprio nell’accezione latina di ri-andare con il cuore (dove i Romani collocavano non tanto i sentimenti quanto la sede dell’io e quindi anche della memoria) a essere il tema centrale della poetica di una delle più famose, efficaci e uniche opere a fumetti mai pubblicate, e cioè Maus di Art Spiegelman. Maus non è soltanto un fumetto, ma un’opera grandiosa, monumentale, immensa, un vero e proprio capolavoro, giusto per usare un’altra parola fin troppo abusata ma che qui riprende tutta la sua efficacia, il vigore del suo significato originario di opera che sancisce tutta l’abilità di un maestro.
È un capolavoro che, come tale, ha avuto una genesi complessa che ha richiesto ben sei anni, dal 1986 al 1991 per essere terminata, perché parla di un tema doloroso da trattare. Maus in tedesco significa infatti topo, e quando si associano topi e fumetti tutti pensiamo immediatamente allo spensierato Topolino creato nel ‘28 da Walt Disney, oppure allo sbarco in America di Fievel, animato da Don Bluth nel 1987, o, per lo meno per quelli dalla memoria più fina, a Ignatz Mouse, protagonista assieme a Krazy Kat delle folli, estrose e lunari strisce di Herrimann più di un secolo fa.
Maus, Fumetto di Topi e Maiali
I topi che disegna Spiegelman però non sono tenere icone pop, sono gli ebrei perseguitati dai tedeschi, scovati e sterminati in quella gigantesca follia collettiva – ma estremamente lucida e consapevole – che fu il Nazismo, perché Maus parla dell’Olocausto e della guerra, o meglio è stato il primo fumetto al mondo a parlarne. E questo tema viene affrontato di petto senza indulgere né nel sentimentalismo stucchevole dell’indignazione fine a se stessa che possono permettersi i privilegiati, né la meccanica rappresentazione del grottesco e dell’orrore materiale dello sterminio, grazie al disegno semplice e spigoloso che inesorabilmente si affila nella costante dicotomia tra bianco e nero, e alla metafora grafica che struttura l’intera opera.
Come da titolo, gli ebrei sono infatti rappresentati come dei topi antropomorfi, braccati da nazisti raffigurati con le fattezze dei loro naturali predatori, i gatti. L’utilizzo di questo espediente non è certo una novità, da sempre gli animali – antropomorfizzati o meno – sono stati utilizzati in letteratura per mettere in scena vizi e virtù della società umana, pensiamo alla favolistica classica di Esopo e di Fedro, alla Batracomiomachia di Omero, alle medievali gesta volpine del Roman de Renart, o alle figure animalesche dei Chōjūgiga giapponesi.
Ma l’effetto è profondamente diverso. In tutti questi esempi l’effetto ricercato è quello della caricatura, di una lettura cioè farsesca e satirica della realtà che metterà pure in scena l’assurdità della realtà, ma sempre con la volontà di divertire. In Maus invece la metafora è parte integrante della narrazione. Gli ebrei sono topi non solo perché i nazisti li trattavano come tali, ma anche perché li rappresentavano così, visivamente e concettualmente: come un’infestazione pericolosa e incontrollata da risolvere una volta per tutte.
Esattamente come i ratti anche gli ebrei si riproducevano nascosti nell’ombra della società ariana, nutrendosene come parassiti portatori di tremende malattie dello spirito e del corpo. Non è un caso infatti che allora le comunità si vantassero di essere Judenrein, “pure da ebrei”, un lessico che riecheggiava consciamente quello della de-rattizzazione; del resto ancora oggi i topi sono tra i pochi animali la cui morte è pressoché incapace di suscitare in noi la benché minima empatia: sono solo una fastidiosa scocciatura.
La zoomorfia non si limita però solo a ebrei e tedeschi, ma si estende a ogni nazionalità raccontata, sempre sospesa a metà tra espediente grafico e giudizio morale, così gli statunitensi, nemici dei tedeschi, sono dei cani (non di razza, sotto-intendendo il melting pot culturale proprio dell’America), gli svedesi alci e i polacchi, ambigui, violenti e opportunisti nei confronti degli ebrei, come dei maiali.
Il tutto è un gioco di maschere animali (animali travestiti da altri animali, l’autore che si rivolge al lettore con indosso una maschera da topo, le riflessioni su come disegnare la moglie, francese ma convertita all’ebraismo) che confonde volutamente le acque. La scelta è valsa a Spiegelman svariate accuse di semplificazione perché trasformerebbe l’intero Olocausto in un rapporto razziale di predatore-preda, come fatto notare dall’artista Ilan Manouach che nel 2012 avrebbe pubblicato Kats (opera poi finita al centro di una causa per plagio e in buona parte distrutta), una rivisitazione di Maus in cui tutti i personaggi erano rappresentati soltanto come gatti.
Seppur criticata, la scelta si rivela vincente e terribilmente efficace: la persecuzione dell’ebreo- topo colpisce in un certo qual modo atavico il lettore costringendolo a fermarsi tavola dopo tavola, come un pellegrino stazione dopo stazione in una claudicante Via Crucis.
Ma Maus non è un libro sull’Olocausto, o meglio, lo è ma è anche e soprattutto qualcos’altro. Il fulcro della storia infatti non sono le vicissitudini di Vladek, ebreo polacco sopravvissuto all’Olocausto e padre di Spiegelman, bensì il rapporto tra questi e i ricordi della guerra e dei campi di concentramento, e come queste memorie, impossibili da dimenticare o da ignorare siano come un colossale monolite che proietta la sua ombra scura tanto su Vladek, che su suo figlio e sul loro rapporto.
La relazione memoriale che si instaura tra padre e figlio, e tra questi e gli avvenimenti di Auschwitz diventano l’asse cartesiano su cui si orienta l’intera opera: i diari della madre di Spiegelman bruciati dal marito che cerca – inutilmente – di liberarsi del ricordo, l’assenza della celebre banda musicale che suonava all’ingresso del Lager e che Vladek nega esistesse, le fotografie dei parenti sopravvissuti e, soprattutto, il fratello maggiore di Spiegelman, Richieu, ucciso dai suoi stessi genitori per risparmiargli l’orrore nazista, un’inquietante e idealizzata presenza, eterno termine di paragone che l’autore si auto-impone e con cui si auto-tormenta, incapace di assolversi dalla colpa di essere sopravvissuto (lui) a una tragedia che non ha nemmeno vissuto.
Vladek non è un eroe come quelli messi in scena da Spielberg o da Benigni, ma una persona reale, a tratti persino antipatica: è cinico, razzista, taccagno, forse persino opportunista, è a tutti gli effetti un sopravvissuto, ma è altresì vivo e pulsante. L’esperienza del campo di concentramento è quindi filtrata attraverso i suoi ricordi, alle sue miserie e alle sue considerazioni: nel raccontare indugia tanto sui grandi orrori quanto, con una certa qual punta di furbesca soddisfazione, sulle conquiste e i sotterfugi escogitati per sopravvivere giorno per giorno.
Quella di Maus tecnicamente è una costruzione titanica, maestosa, che parte da una riflessione sulla lingua utilizzata fino ad arrivare al rapporto tra memoria e narrazione, che non può non domandarsi come Adorno se sia lecito fare poesia dopo Auschwitz, se la sua sia arte o se si sia solo arricchito sui cadaveri di chi là vi è morto. Stampato all’inizio come pubblicazione underground negli USA sulla rivista Raw diretta e fondata dallo stesso Spiegelman, diviene rapidamente un successo, tant’è vero che vince uno speciale Premio Pulitzer nel 1992, unico fumetto ad averlo mai vinto finora.
Ma la sua popolarità è destinata a superare l’oceano, e in questo caso grazie a un italiano, Ugo Cirillo, che nel 1983 lo nota a New York e convince i redattori di Linus ad acquistarne i diritti per cento dollari a pagina, un’enormità per l’epoca, soprattutto perché Spiegelman è molto pignolo riguardo a come essere tradotto, al tipo di carta da usare, al lettering delle vignette.
Ma la pubblicazione di quella che sarà una delle primissime traduzioni importanti del testo, oggi riedita da Einaudi, si rivelerà un successo capace di superare ogni più rosea aspettativa. Spiegelman crea un prodotto troppo grande, troppo voluminoso, troppo intenso perché potesse essere etichettato soltanto come un fumetto, soprattutto nell’accezione che ancora molti hanno di opera per l’infanzia, ma che andrebbe ascritto alle grandi opere della letteratura, un apripista, capace, come tale di riflettere sull’Olocausto e su come questo potesse essere rappresentato.
Come disse lui stesso: “Io, con Maus, ho usato una metafora che si autodistrugge. Non è una metafora che dobbiamo prendere seriamente, dato che ci sono gatti e topi, ecc. Ho usato una metafora che porta a qualcosa di vero. Benigni ha preso qualcosa di vero per fare una metafora. Il contrario.
L’ha usato per dire: Finché hai humor e la luce, la vita è bella. Vaffanculo! […] Quando ho fatto Maus, era un ossimoro. Le persone si aspettavano che fosse davvero qualcosa di estremamente stupido. Un fumetto sull’Olocausto con gatti e topi, che cosa passa per la testa di questo tizio? Non andò a finire in quel modo, e oggi ci sono almeno 20 graphic novel sull’Olocausto. Quello che feci come un’anomalia è diventato un genere”.
SCOPRI TUTTO SUL PROGETTO CHARTA, SPONSORED BY BUONVECCHIO!